Eugenio Pesci è un nome che ho letto sulla rivista UP Climbing un bel giorno in cui ho deciso di abbonarmi per… restare al passo con i tempi, diciamo così. Appassionata di storia, non posso però sempre guardarmi indietro.
Dunque è un nome che continuo a leggere, a firma di editoriali e articoli. E allora penso ‘chissà quante ne ha sentite’. Perché non intervistarlo ed entrare un po’ non solo tra le sue esperienze di redazione, ma anche tra quelle che lo vedono in prima linea sulle pareti? E magari ha anche una visione interessante sul tema dell’alpinismo e dell’arrampicata.
Mi è andata bene: ha accettato. E la mia curiosità ha avuto un esito più che positivo: ascoltare il suo punto di vista è stato non solo molto divertente, ma mi ha fatto riflettere.
Spero che lo stesso effetto lo abbia su di te.
Eugenio, vorrei conoscere meglio la tua storia in rapporto al territorio lecchese, che ti ha adottato e di cui sei diventato ormai uno dei protagonisti. Qual è stato il tuo approccio all’arrampicata?
Quando ero ragazzino, all’età di circa 12 o13 anni, andavo sempre in Dolomiti con i miei. Non sapevo nemmeno dove fossero le Grigne. Poi casualmente il marito della mia maestra, che era la migliore amica di mia mamma, appassionato escursionista, mi ha portato con i suoi figli, miei amici, in Grignetta. Pensa che la prima volta non l’ho neanche vista, perché c’era la nebbia. La seconda volta abbiamo fatto un pezzo del sentiero della Direttissima. Avevo 13 anni.
Inoltre, nonostante non fosse dell’ambiente, mia mamma conobbe Bonatti attraverso una sua amica che scalava e si mise a leggere i suoi libri, quelli di Maestri e di altri alpinisti. Con lei li leggevo anch’io e all’epoca in cui andai in Grigna riconobbi quei luoghi.
Tornato in Dolomiti l’anno successivo con i miei, ho iniziato ad arrampicarmi su tutti i sassi che trovavo e con gli amici è scattata la passione. A 13 anni dunque iniziavamo ad arrampicarci, facevamo quello che oggi si definisce buildering: ci arrampicavamo su qualsiasi struttura, spesso in scarponi, addirittura facevamo le doppie dai balconi!
E poi ricordo che siamo andati a Natale in un negozio in Corso Vittorio Emanuele, che adesso non c’è più, e ci siamo regalati l’attrezzatura.
Mentre scartavo i pacchetti sotto l’albero di Natale, i miei mi guardavano perplessi: c’era l’imbragatura gialla e nera firmata Cassin! La prima corda me l’ha comprata mio padre e da lì abbiamo iniziato, con altri due amici che avevano frequentato un corso roccia al CAI di Milano, ad andare ai sassi del Nibbio, ai Resinelli.
A 15 anni abbiamo iniziato ad andare in Grignetta, a fare qualche modesto tentativo di arrampicata.
Quando avevo 16 anni un amico, che già un po’ scalava, ha insistito per portarmi a salire la Cassin al Medale, all’epoca una via non proprio banale di 400 metri.
Da lì non mi sono più fermato!
Ho comperato le scarpette a suola liscia, fra le prime arrivate in Italia, a Lecco, che venivano dal negozio di Tony Gobbi a Courmayeur, le EB Gratton, e con quelle ho iniziato ad arrampicare su vie alpinistiche nel Lecchese: Medale, Pizzo Boga, Grignetta… sempre con il mio amico Marco Di Franco e altri.

Ripensando a quei tempi, alla fine degli anni ’70, devo dire che un po’ posso considerarmi un sopravvissuto: ammetto che mi era partito il pallino del free solo, scalavo slegato con le Puma gialle e blu a suola liscia. Avevo 16/17 anni e ho salito la Cassin quattro volte slegato, la Via degli Istruttori e altre. Qualche volta usavo anche un cordino che passavo nei chiodi: assurdo se ci penso ora! Se fossi caduto potevano raccogliere i pezzi del mio corpo sparsi per la parete… Tentai anche la prima solitaria della Brianzi al Medale: superai da solo il tiro chiave in quello stile, poi per fortuna mi unii ad un’altra cordata. Dovevo essere leggermente fuori di testa (ride, ndr)!
A 17 anni, con una famosa guida di Canazei che adesso non c’è più, Luciano Ploner, ho salito alcune vie in Dolomiti di quinto grado.
Poi purtroppo, verso i 18 anni, ho iniziato ad avere qualche problema ai tendini e ai muscoli e ho dovuto fermarmi per un po’, quattro anni. Però scalavo già benino per l’epoca: parliamo del ’79-’80 e salivo già tranquillamente il VI, VI+. Quattro anni che hanno coinciso con quelli dell’università.
Successivamente entriamo negli anni ’80, quando nasce l’arrampicata sportiva. Io nell’’83 -’84 ripresi a scalare, ma a un livello più basso dei miei amici che invece non avevano mai smesso. Erano diventati bravi e con loro ho salito una ventina di vie di una certa difficoltà, classiche ma difficili, in Dolomiti.
Poi sono passato all’arrampicata sportiva: all’epoca le vie alpinistiche in Dolomiti più difficili di quelle che avevo già salito passavano a un livello di difficoltà e di rischio che non mi sentivo di affrontare.
Con l’avvento degli spit nel Lecchese, io e i miei amici avevamo la Corna di Medale da riscoprire in un’ottica moderna. E non solo quella parete!
Da lì è iniziata quella che è stata la mia attività principale, cioè l’apertura e l’attrezzatura di vie a carattere sportivo.
Dopo gli anni ’80 e in seguito ci sono stati la Sardegna, il Verdon, la Marmolada, la Val Formazza e tante altre zone, però di base sono rimasto sempre legato alle possibilità che c’erano nel Lecchese, dove ho aperto circa 25 vie con diversi compagni di cordata.

Dato che mi hai citato l’arrampicata sportiva, ti chiedo com’era il mondo prima e come quella sportiva ha influenzato l’alpinismo. Ovviamente voglio conoscere il tuo punto di vista.
Io ho vissuto in prima persona la fase di passaggio da un mondo alpinistico puro, quello trad per intenderci, con chiodi e dadi, senza spit, all’arrampicata sportiva, soprattutto in falesia.
Ti parlo degli anni dal 1978 al 1982 circa, del free climbing, che è diverso dall’arrampicata sportiva, anni in cui l’arrampicata in falesia esisteva e non esisteva.
Io sono andato la prima volta a Finale Ligure nell’’84: c’erano già tantissime vie a spit, però erano i primordi. In quegli anni c’era il movimento del sassismo. A mio parere alla fine degli anni ’70, primi ’80, l’alpinismo su roccia in Italia era in grande stallo.
C’è qualche nome che vuoi citarmi?
Certo, c’erano dei personaggi di riferimento. Penso a Roma Pierluigi Bini: un grandissimo arrampicatore puro, alpinista, che faceva cose pazzesche come la Micheluzzi al Ciavazes slegato, la prima solitaria della Gogna alla Marmolada e da solo anche la Via dei Fachiri alla Scottoni…
Ce n’erano di figure di riferimento, però globalmente, rispetto credo agli anni ’60, ’50 e prima, c’è stata una decadenza, si era arrivati al punto “mo’, ora cosa facciamo?”. Di più non si poteva fare, perché di più voleva dire ammazzarsi con chiodi e qualche dado.
E poi c’era il free climbing degli Stati Uniti e dell’Inghilterra, con grandi personaggi che hanno ispirato i nostri. Ad esempio in Lombardia scalava Ivan Guerini, Manolo, nella sua fase precedente allo spit, e altri. Ivan Guerini, pur con le sue criticità all’epoca, era sicuramente un fenomeno, faceva delle cose a livello fisico che gli altri si sognavano: lo vedevo ai giardinetti di Porta Venezia che faceva degli esercizi mostruosi di ginnastica pura. Era molto avanti.
Successivamente il passaggio è stato molto rapido, perché il free climbing non è durato molto, era per pochi e nel momento in cui questi giovani free climber, più forti dei precedenti alpinisti, si sono resi conto che potevano spingersi più in alto con le difficoltà perché c’era lo spit, la maggior parte l’ha usato, e quindi si è passati a un’arrampicata soprattutto di falesia, alla prestazione pura.
Sì, c’era un po’ la retorica del gesto, del movimento, ma è tramontata col tempo: di base è la prestazione la protagonista. Se ho chiuso il tiro la mattina, sto bene, e se non l’ho fatto, sto male, qualunque sia il grado. Da lì è partita l’arrampicata sportiva.
E il Lecchese, secondo me, è stato un territorio, forse per vicinanza alle grandi città, molto propenso ad accettare l’arrampicata sportiva di falesia e anche poi il passaggio all’arrampicata sportiva su alte pareti. Nel Lecchese quasi mai nessuno si è stracciato le vesti perché si attrezzavano o si aprivano delle vie a spit.
Solo qualche anno fa c’è stata una caterva di polemiche grottesche da parte di alcuni dinosauri invidiosi, ma è un territorio che è sempre stato molto aperto alle novità. Credo anche in relazione al fatto che ci sono gruppi alpinistici ben noti, molte ditte che sponsorizzavano atleti, quindi erano in tanti a essere favorevoli allo spit.
Tu allora mi dici che l’arrampicata sportiva in un certo senso ha influenzato l’alpinismo proprio in quella sua fase di stallo? Con l’aggiunta della prestazione e dello spit per proteggersi.
Devo specificare: c’è una forte differenza tra quello che era il free climbing, il Nuovo Mattino, il sassismo, la Val di Mello, Ivan Guerini, Giancarlo Grassi, tutta la banda del Piemonte… tra il loro modo di intendere l’arrampicata e quella che è l’arrampicata sportiva. Il loro era un mondo che aveva una forte componente spirituale, culturale, intellettuale. Invece l’arrampicatore sportivo fondamentalmente è un atleta, un ginnasta.
È inutile raccontarci cose assurde: uno può costruire tutte le poesie che vuole su un buon tiro, però di fatto è un’esperienza a carattere puramente ginnico!
È curioso che proprio quella forma di emancipazione dall’alpinismo, il free climbing, abbia poi portato all’arrampicata sportiva e sia tramontata in gran parte, almeno in Europa (non negli Stati Uniti e in Inghilterra). Il free climbing è stato una specie di traghettatore che ha generato due filoni: qualcosa di consono al proprio spirito (Motti, Guerini, Grassi e gli altri) e qualcosa di opposto, perché vuoto dei componenti spirituali o intellettuali.
Dopo queste affermazioni devo chiedertelo: come lo vedi il futuro? Abbiamo già fatto tutto e non ci rimane più niente da provare o nulla di nuovo da essere?
Faccio una premessa: già in altri spazi ho espresso i miei pareri sul tema, anche circa 15 anni fa a un congresso del CAI a Predazzo.
Comprendo che possa essere un pensiero tacciato di cinismo, però lo sostengo ancora: la mia impressione è che qualsiasi riflessione sull’alpinismo e sull’arrampicata, fatta dall’interno di questo mondo, sia priva di senso. È necessario uscirne e vedere l’arrampicata e l’alpinismo come una parte, mi spiace dirlo, assolutamente minimale nello sviluppo del mondo.
E vedendola da una prospettiva esterna, c’è una caduta degli idoli, una specie di pulizia: così si può capire cosa stia succedendo. Se invece il tutto viene visto dal dentro, come dissi a suo tempo, non è possibile sviluppare un pensiero critico. In pratica la si canta e la si dice, ma non si arriva a qualcosa di reale.
Attualmente l’alpinismo e l’arrampicata, ma forse di più l’arrampicata sportiva nelle sue varie forme, sono sempre più influenzati da elementi economici, sociali e culturali, purtroppo anche negativi, di una società, come è stata definita da alcuni, turbo-capitalistica.
Alpinismo e arrampicata sono sempre di più un elemento di loisir puro, di sfogo, di appropriazione piacevole di terreni, luoghi ed esperienze, da considerare entro la sua funzione in tutto questo contesto.
Poi ognuno può vivere alpinismo e arrampicata come vuole, certo, questo è fondamentale. C’è chi la vive come un’esperienza di piacere, o mistica, o erotica, o razionale, chi ci vede Dio e via dicendo, ma oggettivamente è una rotellina del sistema. Non credo che questo pensiero faccia piacere a molti, ma è così.
La trasformazione che attualmente è legata alle palestre, a una massificazione radicale, è la prova del nove. Se tu mi chiedi quale sarà il futuro dell’arrampicata, ti rispondo come ho scritto su UP nel numero sulle falesie: non ho una risposta.
Nelle palestre indoor credo ci sarà un enorme sviluppo, soprattutto in due fasce di età: i molto giovani e i molto vecchi, perché è un luogo protetto. Poi il passaggio dall’indoor all’outdoor è tutto da vedere.
Nelle falesie probabilmente ci sarà un aumento dei numeri, ma non per forza un aumento del livello: è crollato paurosamente il livello tecnico, soprattutto perché chi frequentava le falesie anni ’90 sapeva scalare su gradi più alti e oggi la maggioranza scala male, ha bisogno degli spit a 2 metri e se ce n’è uno a quattro torna a casa.
Il livello di punta è invece salito, ma in maniera atipica, perché se parliamo di percentuali non è così. Il livello appare maggiore perché ci sono molti più praticanti, che si allenano in maniera molto più scientifica e quindi ci sono tanti ragazzini che fanno in poco tempo e con più facilità cose che fino a un po’ di tempo fa arrampicatori evoluti facevano in molto più tempo. Ci sono giovanissimi arrampicatori che in 3 anni fanno l’8b o l’8c, impensabile nel passato. Questo è il livello di punta. Ma il livello di base è in regresso mostruoso, come mi dicono anche tanti istruttori.
Il futuro dell’arrampicata è quindi molto legato all’aspetto educazionale e c’è il rischio che diventi (e in parte lo è già, soprattutto quella indoor) un’alternativa del momento alla rumba, al Tai Chi, allo yoga e altro.
L’hai notato? Se tu vai in alcune palestre al coperto, ti chiedi “ma qui chi è che arrampica?”. Perché vedi gente che fa di tutto tranne che arrampicare. Le pareti sono quasi vuote, però c’è quella che fa la spaccata a 300°, l’altro che solleva 200 chili, uno che fa le trazioni con 100 chili di sovraccarico, quell’altro in meditazione trascendentale che vede Dio… e poi, quando chiedi che grado fanno, ti dicono che stanno provando un 7a. Che senso hanno queste altre attività?
L’hai detta in un modo molto simpatico, ma è la dura verità.
Eh, il mondo indoor è quello lì. Anche per quanto riguarda questa iper-frequentazione delle falesie: è vero che c’è, però di quali falesie? Quelle alla moda, come Finale, Arco, oppure falesie di livello molto basso, perché io posso dire che nel Lecchese l’antico Nibbio è deserto. Nelle falesie un po’ più tecniche non ci trovi nessuno. Se c’è da camminare non parliamone. Se la chiodatura è un po’ distante, apriti cielo!
Nel numero di UP sulle falesie abbiamo cercato di fare un quadro della situazione.

L’ho letto: molto interessante, anche conoscere il parere di diversi arrampicatori. Che mi dici dell’alpinismo?
Non saprei dirti: è chiaro che l’alpinismo ha un fascino diverso. Quello che mi sento di dire è che da quello che vedo l’alpinismo, su roccia e misto, attrae molto. Una parte di frequentatori nuovi è molto capace, sono giovani e bravi, più di prima, però poi c’è il rovescio della medaglia: c’è un altro 50% di gente che non ci capisce nulla, va allo sbaraglio e rischia parecchio, perché l’alpinismo, soprattutto quello medio facile, è una pratica molto pericolosa, addirittura più di quello difficile.
Questo è un aspetto interessante, soprattutto per chi si approccia all’alpinismo.
Se vai a fare ad esempio la Vinatzer-Messner in Marmolada, che è già una classica, non puoi essere uno sprovveduto, perché non arrivi al terzo tiro. Se invece vai a fare la cresta Segantini in Grignetta, puoi essere uno sprovveduto.
Tutto questo è molto grave perché, visto il sovraffollamento turistico attuale, apre scenari catastrofici, come ben si è visto negli ultimi due mesi sulle Alpi.
Quindi, per non essere sprovveduti, tu cosa consigli ai ragazzi? Di fare dei corsi, ad esempio?
Assolutamente sì, soprattutto chi vuole scalare outdoor.
Se uno ha già scalato indoor, benissimo, ma non deve pensare di essere abilitato automaticamente per l’esterno: dovrebbe fare uno step intermedio. Che sia con il CAI o con la guida alpina o con un amico molto più capace, tutto va bene, l’importante è non improvvisarsi.
E lasciamo perdere quel che gira in rete, gli influencer di vario genere, personaggi che… lì diventa drammatica la cosa.
Ma, per concludere il discorso, il grande problema non è l’arrampicata in falesia, dove l’ambiente è protetto ed è difficile farsi male, e non è l’alpinismo, che implica un insieme di conoscenze: è l’escursionismo, perché è alla portata di chiunque, è rischioso perché tra gli escursionisti c’è chi non si rende conto quanto sia pericoloso cadere di testa su un pendio di 30° per due metri. Significa finire all’ospedale, se non al cimitero.
È l’escursionismo la grande falla del sistema in questa situazione di sovraffollamento verticale. Il problema lo è meno l’alpinismo, che è una pratica elitaria, e ancora meno l’arrampicata in falesia o il boulder, dove al massimo ti storci un ginocchio.
Sempre in relazione ai primi approcci, una domanda che spesso ci si sente porre è ‘che via mi consigli di fare?’. In molti giustamente rispondono che dipende dal grado che si ha, da cosa si è abituati a fare… Se tu dovessi consigliare delle vie, su quali parametri ti baseresti: quali sono per te gli elementi davvero rilevanti per suggerire una salita?
Io direi che in base alle proprie capacità, dopo un’autovalutazione molto cinica di quello che ci si sente di fare, di quello che si è in grado di fare realmente, io credo che di una via bisognerebbe sapere con precisione la difficoltà obbligatoria dei passaggi. Perché uno può salire una via di 7a, ma se l’obbligatorio è 5c, il problema si pone meno. Se invece si sale una via di 6b e l’obbligatorio è 6b, bisogna saperlo fare questo 6b.
Il secondo elemento da conoscere è il tipo, la sicurezza e le distanze della chiodatura. Perché tu puoi saper fare il VI, ma se la via è chiodata a 6 metri, ad esempio, devi essere consapevole che se cadi con il chiodo a 4 metri sotto di te, ti fai una decina di metri di volo contando anche l’allungamento della corda, e potresti farti male.
Poi c’è la logistica dell’itinerario: l’avvicinamento, le possibilità di discesa, la distanza dai punti di appoggio…
Senza dimenticare l’elemento meteorologico. Oggi c’è la possibilità di conoscere in dettaglio tutto, quindi ci sono dei luoghi (come le grandi pareti dolomitiche o in alta quota) dove, se il meteo non è certo, è bene non andare.
Chi si lascia tentare dall’enfasi epica della sublimazione, dal sorriso del lunedì mattina perché gli è riuscita la via, può farlo. Ognuno deve fare quello che vuole. Però sottolineo che io lo sconsiglio.
Se poi uno vuole avventurarsi su itinerari trad, entrano in gioco altre questioni come la valutazione delle proprie capacità di mettere le protezioni, puramente tecnico-alpinistiche.
Qualche altro alpinista che ho intervistato mi ha detto che questa parola proprio non gli piace, ma al momento è quella che mi viene più comoda: etica. Tu hai aperto tantissime vie. Qual è la tua etica di apertura?
Io ho fatto una scelta. Per qualche anno da giovane, attorno ai vent’anni, ho salito vie abbastanza difficili, puramente alpinistiche, cioè protette a chiodi e da integrare con qualche nut o qualche friend, ma già all’epoca ho trovato questo tipo di attività, per quanto mi riguarda, un po’ fuori luogo, troppo rischiose.
Io ho sempre vissuto l’arrampicata come un fatto creativo e la vedo tuttora così, quindi ho pensato che sviluppare una visione (non uso la parola etica perché la trovo fuori luogo) creativa legata a una certa sicurezza fosse l’elemento principale.
La mia idea di fondo è evitare di aprire o attrezzare delle vie dove sia possibile farsi male seriamente in caso di caduta. Mi è anche capitato più di una volta di fare a vista dei passaggi senza mettere fix e in un secondo momento, in calata, aggiungerne uno o due.
Non c’è mai stata una componente di esaltazione nel mio modo di aprire le vie. Penso che la cosa essenziale sia creare un bell’itinerario, che sia godibile e che piaccia a chi lo fa, magari inserendoci delle difficoltà obbligatorie, ma in una condizione che garantisca una certa sicurezza.
Però qualche volta hai sgarrato!
Sì, ho aperto vie anche con alcuni che la pensavano diversamente da me. Ad esempio quella al Sasso Cavallo con Matteo Della Bordella: la via l’ha aperta prevalentemente lui, S4 con un tiro di 7b in cui gli spit sono a 9 metri… però è Matteo Della Bordella, non Eugenio Pesci (ride, ndr). Io lì l’ho seguito su una via sportiva di carattere, di alto livello, ma che non fa parte del mio background tecnico-atletico.
Oltre alla tua esperienza alpinistica, c’è anche quella come direttore editoriale della rivista UP Climbing (e non solo), quindi ne avrai sentite tante. Qual è la visione, il metodo che ti ha più incuriosito o sorpreso?
Fare dei singoli nomi mi risulta difficile. Quello che mi colpisce sempre è come ci siano degli arrampicatori, ovviamente personaggi noti e relativamente giovani, under 40 per intenderci, che fanno delle cose estreme con una sorprendente nonchalance interiore.
Un tempo, quando ho iniziato nel 1985 a occuparmi di giornalismo con la rivista Alp, la Rivista della Montagna, e andavo a intervistare grandi nomi, c’era una grande enfasi, tranne rari casi come i francesi. Gli altri ci tenevano a rimarcare quanto fosse stata pesante, difficile, grandiosa la loro attività alpinistica. Oggi invece ci sono molti che senza tanta retorica affrontano grandi imprese, ma dal punto di vista interiore riescono a non trasmettere più di tanto l’adrenalina: sembra che per loro sia un’attività normale. Ad esempio, la salita in solitaria che ha fatto Ragazzo alla Torre di Trango, Eternal Flame: un’azione di una difficoltà stratosferica, che è stata molto mediatizzata, ma secondo me neanche poi tanto. E lui stesso non è che abbia caricato i toni: io credo che l’abbia vissuta con una certa libertà e con un animo calmo. E questo anni fa, quando ero un ragazzo, non accadeva. C’era sempre molto pathos. Forse dipende dal fatto che oggi i ragazzi hanno una capacità fisico-atletica molto più elevata.

C’è anche stata un’evoluzione nel modo di vedere, nel modo di pensare l’arrampicata, è corretto? Dalla conquista della vetta, lo stato di sofferenza e sacrificio, a quello che è stato il pensiero del Nuovo Mattino, che ha un po’ cambiato il modo di vedere le cose, fino al mondo attuale in cui i giovani vivono l’arrampicata chi concentrandosi sulla prestazione chi sulla pura avventura…
Sì, assolutamente.
Ho intervistato anche molte donne: abbiamo fatto 4 anni fa un numero dedicato solo alle donne arrampicatrici, che rimane una delle mie uscite preferite della rivista. Penso alle massime arrampicatrici mondiali e devo dire che, tolti due o tre casi in cui c’era una certa tendenza auto-psicanalitica sulle tecniche eccetera, le altre sono state veramente molto libere mentalmente nel raccontare la loro esperienza: la vivono bene, nonostante abbiano svolto delle attività molto rilevanti a livello arrampicatorio e alpinistico. E ci tengo a dirlo: rispetto a delle figure di bassissimo livello che imperversano in rete, queste sono di un livello 10 volte superiore e non se la tirano minimamente, al massimo diffondono l’aspetto tecnico. E potrei farti anche dei nomi: l’americana Emily Harrington, la svizzera Nina Caprez e altri mostri sacri. Queste potrebbero dire quello che vogliono eppure si sono dimostrate pacate, di una tranquillità assoluta, disponibili a parlare di sé senza aggressività mediatica.
In rete c’è gente che pensa che fare un 8a ormai faccia notizia. Ma Raffaella Valsecchi ha salito il primo 8b in Italia senza quattro dita 30 anni fa, nel 1990 a Cornalba.

Hai intervistato parecchi personaggi: quale ti ha più incuriosito?
Fammi pensare… Così su due piedi è difficile. Forse per la sua semplicità Igor Koller: è una persona che a 70 anni scala ancora su gradi elevati, attivissimo sotto vari profili.
Poi c’è Denis Urubko, himalayista: un personaggio molto simpatico che non fa minimamente retorica.
Tra i sassisti Niki Ceria è sicuro un riferimento: uno di altissimo livello che ha una visione del boulder molto evoluta.



Tra gli arrampicatori sportivi non saprei farti dei nomi, però uno mi ha colpito molto quando era un ragazzino: tanti anni fa avevo seguito Ondra e all’epoca era di un altro pianeta sotto tutti i profili. Pensa che a 16 anni nella falesia di Fopela al passo della Presolana aveva liberato un 8b+ a vista e sceso dal tiro, altri avrebbero telefonato a Famiglia Cristiana per far uscire un numero speciale (ride, ndr). Lui si è messo seduto sul prato dicendo “ora devo fare i compiti di matematica”. Per l’epoca, era il 2007 credo, un 8b+ a vista in Lombardia penso non l’avesse mai fatto nessuno. Lui era stato in parete 40 minuti e poi tutto tranquillo è sceso per fare i compiti.
E di alpinisti che non ci sono più, chi avresti voluto intervistare?
Renato Casarotto e Paul Preuss, che ha salito il Campanile Basso per una via di quinto grado non facile ed è pure sceso, slegato. Mi verrebbe da chiedergli “ma qual è il tuo pusher?” (ride, ndr).

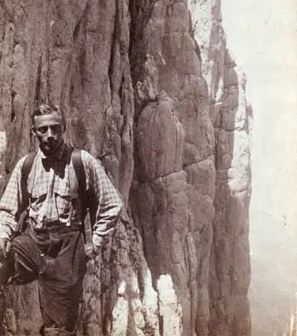
Perché Renato Casarotto?
Perché dopo Bonatti credo sia stato il più forte alpinista per completezza del secondo dopoguerra. Aveva una preparazione a 360°, da Iron Man! Ha fatto imprese straordinarie, fra cui l’ultimo tentativo in solitaria alla Magic line del K2, tanto per citarne una. Sicuramente è stato pari a Bonatti e Messner, ma purtroppo non è vissuto abbastanza.
Mi sarebbe piaciuto sapere cosa gli permetteva di resistere in quelle condizioni, perché per fare quello che ha fatto non basta la forza.
Data anche la tua formazione e il tuo lavoro, sarei curiosa di conoscere la tua filosofia in campo alpinistico.
Te la riassumo.
L’alpinismo e l’arrampicata io li ho sempre visti come delle libere espressioni interiori che si traducono in attività pratiche, fisiche: un’espressione di libertà. Quindi mettere dei paletti, dei vincoli, secondo me è sempre negativo. Imporre delle regole è negativo.
Tra parentesi, non sono d’accordo quando gli itinerari tracciati sono visti come quadri dipinti da pittori, che l’apertura di una via sia paragonata a una forma artistica. L’arte è un’altra cosa per me.
Ognuno deve essere libero di vivere questa attività come vuole. Questo è essenziale. Dire “tu devi fare così, devi sentirla in questo modo…” è quanto di più anti-alpinistico ci possa essere.
Io ho sempre vissuto l’alpinismo come un qualcosa di creativo e quindi mi è sempre piaciuto andare a cercare possibilità creative, che sia un monotiro in falesia o una via multipitch.
E credo fermamente che fare qualcosa di nuovo sia fondamentale. Non vorrei sminuire coloro che non lo fanno, però l’avevano già detto Stefan Glowacz e Michel Piola: il motore di queste attività restano coloro che fanno cose nuove, perché se non ci fossero loro, nello spazio di 10 anni finirebbe tutto.
Senza voler offendere nessuno, penso ci sia una differenza rilevante di impegno tra chi fruisce solo e chi crea, non sei d’accordo?
Certo.
A mio parere comunque l’alpinismo, da un punto di vista morale e guardandolo dal di fuori, è eticamente indifendibile, è una pratica inutile.
È un’attività pericolosissima, non serve a un tubo, spesso finisce sui media con i morti, salvo qualche grande impresa.
E allora perché?
Perché l’alpinsimo è una sublimazione, uno sfogo dalle frustrazioni della vita. Offre un aspetto metabolico, adrenalinico, che altre attività non danno. È esteticamente molto gradevole, soprattutto in quota o in begli ambienti. Quindi c’è una triade di elementi psicologico, estetico e fisico-metabolico, secondo me, che porta verso questo tipo di esperienze.
Resto dell’idea che l’alpinismo sia una funzione secondaria del sistema capitalistico. Però non sono il solo a dirlo… Qualcuno l’ha definito l’invenzione di un cosmo borghese, una forma di appropriazione territoriale, di conquista della borghesia europea.
Insomma siamo dei viziati capricciosi che vogliono fare imprese eroiche…
Ma no, adesso non voglio svilire la pratica. In confidenza, più volte ho accarezzato l’idea di scrivere un testo intitolato anti-alpinismo.
È una bellissima attività, pura libertà di espressione. Questo è essenziale.
Però permettimi di dirti una cosa: rispetto i tuoi pensieri, che in buona parte condivido, ma non pensi che questi ragionamenti si tenda a farli sempre dopo che si è vissuto l’alpinismo? Insomma, a gioco fatto, non prima. Mi spiego: prima ci si gode per bene la pratica e poi si fanno i discorsi, le riflessioni…
Certo, d’accordo. È proprio quella componente sublimativa dell’attività, di cui ti parlavo prima, che ci porta a praticarla. Però poi se la vedo con obiettività e con senso critico, dal di fuori, giudico l’alpinismo e l’arrampicata eticamente indifendibili.
Con il senno di poi, quindi con la mentalità che hai adesso, rifaresti quello che hai fatto?
Mi darei a una pratica solo sportiva.
Colpo di scena.
Da giovane, anche se non ho fatto cose eclatanti, ho rischiato troppo per un pericolo ‘stupido’. Sono un sopravvissuto anche io. Tanti altri non lo sono stati. Ricordo Alessandro Gogna quando mi ha detto: “guarda, ho l’album di foto dei miei amici che è una fila di croci”. Non è il mio caso, ma se ti dovessi contare il numero di quelli che sono passati a miglior vita tra i miei conoscenti, finiamo l’intervista tra due ore. E alcuni nelle circostanze più assurde: non scendendo dall’Everest, ma cadendo in falesia e picchiando la testa!
La montagna è severa.
E non sopporto quelli che trasformano le loro esigenze psicologiche, sublimative o di frustrazione, in qualcosa di oggettivo affermando “l’alpinismo è quella cosa lì”.
Lo stesso Messner ha affermato “l’alpinismo è rischioso”. Ma non deve essere per forza rischio: dire questo è eticamente sbagliato, laddove per etica si intende la disciplina filosofica che tratta del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto. Puoi dire “lo faccio”, ma devi renderti conto che implichi altre persone.
Quindi io, se tornassi indietro, eliminerei l’aspetto del rischio laddove è possibile, tenendo conto che l’attività outdoor comunque impone un rischio, anche se stupido: tutte le attività antigravitazionali, anche se sei a 3 metri da terra, impongono un rischio, perché se cadi per terra ti fai male.
Il rischio è connaturato. Ma la retorica del rischio non l’ammetto. Non non mi piace. Oggi a mio parere è deprecabile. 50 anni fa no, oggi sì.

Ora ti pongo tre domandine in velocità, delle curiosità simpatiche. Quali sono gli argomenti più scomodi per un arrampicatore?
Innanzitutto secondo me molti, nel momento in cui tu vai a toccare le loro prestazioni, le trattano in maniera alquanto protettiva. Manca un po’ di understatement in certi casi. E poi molti ancora tendono a essere poco autoironici: non riescono a vedere dal di fuori. È ovvio che questo tipo di pratiche sono molto autoriferite, endogamiche, anche psicologicamente: possono essere considerate un po’ delle vie di fuga. È sempre stato così, no?
Non a caso la gente comune dice “ah, quei pazzi che vanno a scalare!”. Be’, c’è un fondo di verità. È gente che si auto-esilia in un altro mondo.
La cosa più difficile per molti è probabilmente ammettere che esista un mondo oggettivo e tornare almeno ogni tanto in esso.
Su cosa arrampicatori e alpinisti battibeccano più spesso?
Ci sono parecchie inimicizie dovute a sgarbi legati a gradi e cose del genere.
Senza fare nomi, per la rivista spesso ci siamo scontrati con screzi del tipo “ah se scrive lui, io non scrivo!” oppure “ho sentito che c’è anche tizio e allora io non voglio l’intervista”.
È un mondo di gente poco autocritica e qualche volta un po’ invidiosa.
È proprio una caratteristica degli arrampicatori?
Più di quelli del passato, forse. Tra i giovani c’è poco risentimento, più onestà intellettuale, meno retorica.
E qual è stata, secondo te, la contraddizione più sorprendente nel mondo dell’alpinismo e dell’arrampicata?
Torniamo allo stesso punto: io credo che la contraddizione sia quella di voler mediatizzare l’alpinsimo e l’arrampicata, benché sia in realtà una pratica semi-inutile, salvo alcune eccezioni.
Libri, guide, articoli, radio, social… ma è sempre stato un mondo autoriferito: non è stato capace di mediatizzarsi uscendo da sé stesso per guardarsi dall’esterno, da una prospettiva neutra.
È la prospettiva a essere sbagliata, perché è autocelebrativa.
Il grande elemento farlocco dell’alpinismo è proprio questo.
Grazie Eugenio!
Cosa ci riserva il futuro? Pare che nessuno abbia le idee chiare, ma quel che a noi interessa è il presente e di questo nessuno ha dubbi. O meglio, ognuno ha le proprie certezze.
Ed è affascinante ascoltarle, perché queste arrivano dall’esperienza, da chi ha vissuto realmente ciò di cui parla.
Le parole non bastano, è vero, ma senza di loro come potremmo condividere tra noi tutto questo? Ascoltare i racconti di altri ci aiuta a comprendere, o perlomeno conoscere, punti di vista diversi dai nostri, per aprire la mente e capire che c’è ancora spazio per nuove informazioni, che cambiare opinione è possibile, che metterci in discussione è la migliore cura al nostro porci limiti.
[In copertina: “In cima al Sasso Cavallo alla fine dell’apertura di Blu nord (7b+) nel 2022 con Marta Pirovano. Foto Marta Pirovano – archivio Eugenio Pesci”]


Di’ la tua!