“Ma lo vuoi il contatto di Enrico? Lui sì che ne sa.”
Andrea Giorda mi ha fatto un altro regalo. E pensare che non ho mai voluto neanche chiederglielo. Che domande potrei fare io a Enrico Camanni?
Il suo nome l’ho letto la prima volta quando mi sono innamorata delle storia dell’alpinismo leggendo il libro di Gian Piero Motti. Tutto il resto è ancora storia, con un pizzico di presente e un futuro che rimane il mistero più interessante.
Le domande da fare a Enrico le ho trovate, anche se non le ho poste tutte, erano troppe. E l’intervista è nata.
Enrico, cosa volevi fare da grande?
Quando lo dicevo a mio padre, lui non era assolutamente d’accordo. Volevo fare o la guida alpina o il giornalista, perché mi piacevano la montagna e la scrittura. Matematica per me era uno strazio, invece i temi mi venivano bene. La scrittura e la montagna le avevo nel sangue, ma per la famiglia sarei stato destinato a fare medicina, perché sono figlio di un medico, nipote di un medico, mio bisnonno era medico… in una famiglia di medici, in quanto figlio primogenito, credo che un po’ mio papà ci contasse.
Ma appena ho conseguito la maturità, sono entrato alla Rivista della Montagna, a 18 anni e mezzo, e da lì è iniziata la storia. Ho voluto studiare ancora all’università, quello che mi piaceva, però mi volevo mantenere e quindi ho sposato le mie due passioni: scrittura e alpinismo.
Per fortuna mio fratello ha fatto il medico, quindi la storia della famiglia è salva (ride, ndr).

Giornalista sei diventato, ma guida alpina?
No, ho rinunciato, anche perché due cose insieme mi sembrava troppo: a me piace impegnarmi in quello che faccio, studiavo ancora all’inizio, quando entrai in redazione. Ho praticato l’alpinismo liberamente e la montagna l’ho vissuta anche dalla parte della scrittura, del giornalismo.
Mi piace moltissimo farlo, ancora adesso: ricordo con grande passione quegli anni in cui facevo la gavetta, mi occupavo delle fotocopie e di tutto il resto, però poi ho cominciato a scrivere, ho conosciuto i miei miti… È stato un bellissimo periodo.
Quale tuo libro hai scritto con più fatica, magari per la complessità degli argomenti o perché era difficile esprimere con le parole giuste determinati concetti?
Se li leggo ora, considero i miei primi libri un po’ scolastici: erano i libri di un ragazzo, anche un po’ pedanti. Ho impiegato parecchio tempo a compiere il passaggio dalla saggistica al romanzo, che era un po’ il mio sogno. Il romanzo è tutt’altra cosa, un’altra storia.
Posso dirti il libro che mi ha liberato: è stato, anzi, sono stati due, il primo è il romanzo di fantasia La notte del Cervino. Avevo 40 anni, avevo già scritto due romanzi storici (La guerra di Joseph e Cieli di pietra), ma il romanzo storico mi viene meglio, perché è un po’ il mio lavoro e all’università ho studiato storia.
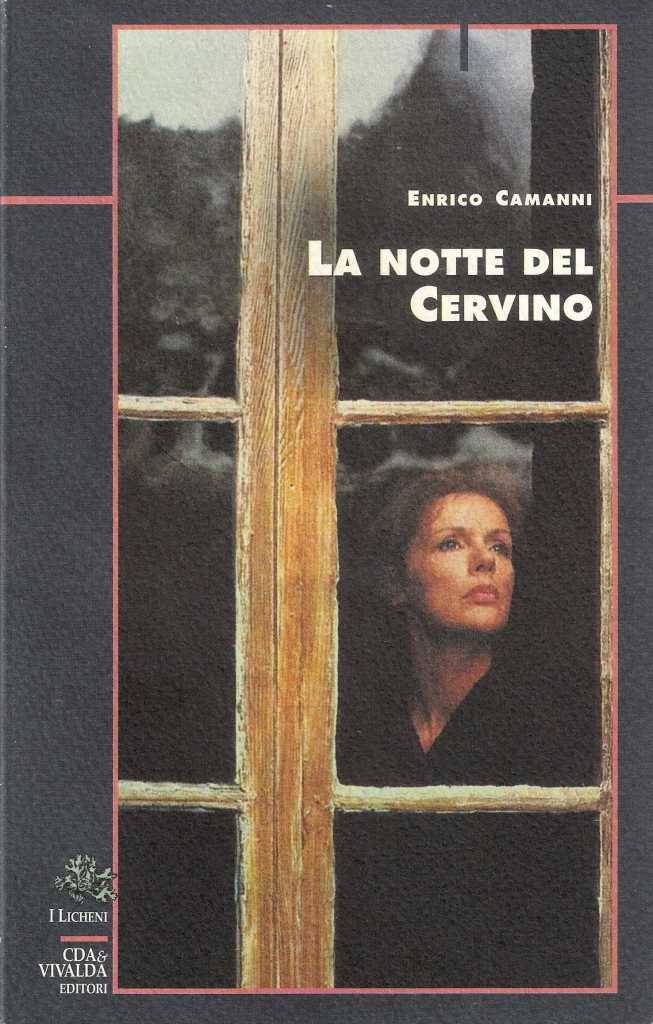
Con La notte del Cervino, del 2003, mi sono buttato sulla pura fantasia, mi sono messo nei panni di una donna: racconto in prima persona dal punto di vista femminile. Alcune donne che l’hanno letto mi hanno detto che ci ho azzeccato, allora mi sono tranquillizzato: è stato uno sblocco anche psicologico passare da un testo pieno di riferimenti storici a un testo attaccato solo alle tue immagini, di fantasia.
Però il libro dove forse mi sono impegnato di più è stato recente, quello su Gary Hemming, Se non dovessi tornare, perché mi ha preso tantissimo il personaggio, la sua storia.
Ma dire quale libro mi ha davvero impegnato di più è un po’ difficile…
Capisco. Come mai proprio lui?
Diciamo che avevo frequentato Gary Hemming attraverso i suoi pochi scritti e quello che mi aveva raccontato Gian Piero Motti.

Infatti proprio per questo è strano: non l’hai conosciuto eppure te ne sei interessato così tanto…
Mi ha sempre colpito tantissimo, soprattutto quando con Gobetti abbiamo tradotto per la Rivista della Montagna, nei primi tempi, il suo articolo sul salvataggio al Dru, che era sconosciuto in Italia: è stato sorprendente come abbia pensato di mettere insieme l’elicottero del soccorso al Dru con gli elicotteri del Vietnam, una visione incredibilmente moderna. E poi a me piace tanto perché per me l’alpinismo, se non è calato in qualche modo nella terra, rischia di non essere niente. Invece Hemming era un uomo pieno di contraddizioni, ma trasparente, con tutte le sue fragilità. Per questo mi ha sempre affascinato. Poi quando Mirella Tenderini ha scritto la sua biografia, io dirigevo la collana dei Licheni e avevo seguito con lei tutte le sue ricerche.
Era un personaggio che avevo in testa da sempre, però non avevo mai pensato di scriverne un libro. Quando Mondadori per la collana Strade blu mi ha chiesto un romanzo, ho pensato che potevo provarci, che la vita di Hemming era già un romanzo. Ma forse è stata proprio questa la difficoltà: sarebbe stato più facile romanzare una storia comune, invece che dare un corpo a una storia così pazzesca, piena di contenuti, di sentimenti.
Mi hai detto che hai scelto gli studi storici, quindi ti anticipo una domanda: quanto è importante conoscere la storia dell’alpinismo per capire l’alpinismo e come si pratica?
Per me è sempre stato molto importante.
So che c’è un sacco di gente che non sa nulla della storia dell’alpinismo e che ugualmente sa andare in montagna, non c’è niente di male. Però per me è sempre stato un valore aggiunto: sapere che lì c’è stata quella storia, che lì c’è passata quella persona. Conoscere la sua vita è come fare insieme due viaggi, non trovi?
Uno è un viaggio sulla montagna e uno è un viaggio nella storia. Io l’ho sempre vista così.
A volte questo mi ha un po’ frenato, perché quando una via è firmata da un grande alpinista, capita che ci si faccia un mucchio di patemi, come dirsi che non si è all’altezza. Quindi sicuramente la storia dell’alpinismo non mi ha agevolato dal punto di vista dei tabù, me ne sono costruiti fin troppi, però mi ha aiutato molto a dare una complessità a quello che facevo.
Quindi non è solo da nerd conoscere la storia?
Secondo me è bellissima la storia dell’alpinismo. A volte è più bella la storia della storia degli alpinisti, perché loro in fin dei conti sono persone, no? Piene di difetti, ma che però hanno fatto delle cose abbastanza eccezionali, non tutti, ma alcuni.
La storia non mi ha ancora annoiato. Gli alpinisti sì a volte, ma la storia no.
Adesso te lo devo chiedere! Perché a volte gli alpinisti sì?
Gli alpinisti sono dei pazzi, in senso affettuoso. Sono dei narcisisti, egocentrici, pieni di manie. E devi proprio volergli bene per stargli accanto. Quando invece ripeti una loro via, diventa tutto più semplice.
E allora ti anticipo anche un’altra domanda. Spesso si definisce l’alpinista un egoista. Sei d’accordo?
Direi più che altro un egocentrico: una persona che è talmente presa dalla propria passione, che sembra vivere in un altro mondo. E parlo anche per me, perché ci sono passato e ci ho messo anni a uscire da quello stato: sei talmente preso dalla tua passione che fai fatica a vedere quello che c’è intorno, perché ti sembra tutto piccolino, inferiore, meno interessante. Questo dialogo con la montagna ti porta sempre più lontano e tutto il resto rimane un po’ secondario.
È un po’ come un grande amore tra le persone, quando ci si chiude tra sé in una coppia, finché non ti accorgi che poi ne rimani soffocato e allora devi trovare dei sistemi per uscirne. Ma non è affatto facile.
Secondo me sulla montagna proiettiamo delle immagini, dei concetti molto simili a quelli che proiettiamo su una donna o un uomo, quindi alla fine ci sembra che la montagna sia l’unica a poterci dare delle risposte. Invece non è vero, perché è tutto un gioco che facciamo dentro di noi alla fine.

Ti sei sentito anche tu un fallito, Enrico?
Io frequentavo molto Motti: è stato un po’ il mio maestro. Aveva 10 anni più di me, quindi per noi giovanissimi era chiaramente un po’ come un fratello maggiore. C’è stato un periodo che sì, assolutamente, mi sentivo un drogato di montagna, uno che aveva bisogno della sua dose domenicale e che non riusciva invece a costruire qualcosa nel mondo ‘pianeggiante’.
A uscire da questo vortice mi ha aiutato tanto la scrittura: portare sulla carta delle pulsioni troppo verticali.
La montagna mi è stata maestra in due sensi. Da un lato la passione e dall’altro è stata un mezzo per scoprire il mondo. E per questo le sono molto grato.
Se invece avessi continuato verso le vette eccelse sarei finito malissimo, nel senso che non sarei stato per niente contento di me. Già non lo ero a 20 anni a volte! Tornavo a casa e dicevo “e adesso cosa mi invento?”. Perché poi non basta mai, hai bisogno di puntare sempre più in alto.
Ricordo quella volta che ho avuto una crisi… Tu avevi le vertigini: ebbene anch’io le ho avute e da bambino rimanevo malissimo quando, per esempio, costringevo mio papà a portarmi in montagna e poi, quando arrivavamo in un posto dove c’era un po’ di vuoto intorno, io restavo bloccato per le vertigini. Poi le ho superate, grazie al fatto che volevo a tutti i costi arrampicare. Ma quando mi sono trovato nella situazione in cui mi sentivo quasi drogato, dipendente dalla montagna, mi sono tornate le vertigini, come se il corpo mi dicesse “guarda che il tuo fisico non vuole fare questa cosa, perché non sei tu, quindi datti una regolata!”. Quando successe questo, per anni ho arrampicato poco e male, ogni volta non ero soddisfatto, non mi piaceva abbastanza, come prima. Però capii che questo passaggio era necessario, per ridimensionare un sacco di aspetti della mia vita.
Quindi la vertigine è anche un segnale che secondo me il cervello ti invia. Ma ci sono anche persone che non sanno cosa siano le vertigini, quindi buon per loro.

Sì, il cervello ci lancia un sacco di segnali, e anche il corpo. Sta a noi capirli. E allora ti chiedo: qual è il limite che ti è stato più utile nella tua attività alpinistica e nella tua carriera letteraria?
Siamo soliti a concepire il limite come un concetto negativo. In realtà il limite può essere anche visto in maniera positiva. Vorrei capire se nella tua vita c’è stato un limite utile, magari per comprendere certi aspetti. Ad esempio le tue vertigini, come mi hai raccontato prima…
Le vertigini sono state un limite enorme. Avevo circa 23 anni quando mi stavo per inoltrare nell’avventura di Alp, la mia fortuna dal punto di vista professionale. In quegli anni scalavo veramente bene, era qualcosa che mi veniva naturale, ma a un tratto mi sono trovato bloccato su difficoltà di III-IV grado, come un principiante. Ero inchiodato alla roccia. Questo è stato un limite che ho sperimentato in un modo brutale, perché è come se ti tagliassero un braccio, non sei neanche l’ombra di quello che eri prima.
E allora devi capire che non è una questione fisica, ma che dietro c’è tanto altro. Quindi nella mia attività alpinistica quello è sicuramente stato il limite.
Dal punto di vista tecnico, invece, credo di non aver mai esplorato il mio limite: sono sempre stato abbastanza prudente. A me interessavano più le belle vie, non di fare la prima ascensione qui o là, oppure la prima invernale… penso di essere sempre rimasto un po’ sotto il mio limite e non mi interessava tanto arrivarci.
Le vertigini sono state una scuola di umiltà, una batosta per dirmi “adesso calmati, scendi dal tuo piedistallo, rimettiti a camminare e cerca di capire che cosa vuoi nella vita”.
Invece nella scrittura il mio limite era nettissimo: sapevo di essere un bravo giornalista, perché mi davo da fare, mi piaceva, capivo le persone, ma ogni volta che provavo a scrivere un racconto, ad esempio, di fantasia, mi accorgevo del mio limite, non mi lasciavo andare, ero bloccato, troppo pedante, non mi piacevo. Quindi piuttosto di scrivere un libro in quel modo, ho preferito sempre evitare quella strada. Finché si è sbloccato qualcosa.

Ti sei sbloccato alla grande, direi!
Faccio sempre questo esempio. Quando avevo circa 35 anni ho imparato a fare snowboard. Sciavo da una vita, ma così per cambiare un amico, Andrea Giorda che conosci bene, mi ha detto “prova!”. Ci siamo scambiati l’attrezzatura: lui mi ha dato la tavola e io a lui gli sci, e mi sono accorto che ero inchiodato, perché tu puoi sciare bene finché vuoi, ma sulla tavola è tutta un’altra cosa!
Mi ci è voluta più di qualche sessione perché finalmente la mia testa non ragionasse più da sciatore, ma cominciasse a farlo da snowboarder, lasciarmi andare, insomma.
Lo stesso è stato per la scrittura. Secondo me tra scrivere da giornalista e da ‘romanziere’ c’è un po’ quella differenza presente tra sci e snowboard: il giornalismo è più di testa, coi due piedi piantati sugli sci, invece la narrativa è un po’ come la tavola, devi lasciare che sia il terreno a portarti e che la mente si liberi.
È stato un passaggio simile a quanto è successo con le vertigini: a un certo punto queste sono andate via, però per accadere deve sbloccarsi qualcosa.
Oggi io alterno saggi, romanzi, ma è sempre il romanzo a impegnarmi di più. Anche se pare mi vengano abbastanza bene entrambi.
Confermo. Ma per sbloccarti, gli input sono stati più esterni o interni?
Secondo me interni.
Ricordo che negli anni in cui sono diventato freelance, avevo due figli piccoli, una famiglia da mantenere, e non avere più il mio giornale che mi dava lo stipendio è stato un salto nel vuoto: all’inizio mi faceva paura, ma poi mi ha liberato, perché ho capito che sì, se vinci la paura, la libertà è impagabile.
Quello è stato uno dei passi determinanti nella mia vita. Infatti più o meno nello stesso periodo ho ricominciato a scalare senza paura, ho iniziato a scrivere narrativa. Dopo quello adolescenziale con le vertigini, lavorare in proprio è stato il mio secondo sblocco.
Già: quando trovi la libertà, è difficile tornare indietro.
Infatti quando vedo persone che a 40 anni si presentano tutte le mattine allo stesso posto di lavoro, no, non le invidio.
‘Mal di montagna. Quindici storie di passione’: ovviamente invito a leggere il libro per saperne di più, ma ti chiedo perché hai scelto il termine ‘malattia’ e se ne sei stato contagiato anche tu.
Sì, ne parlo proprio nel libro, perché è un’esperienza che ho vissuto come poche altre, quindi non è solo uno sguardo sugli altri, ma innanzitutto su me stesso.
Questi 15 personaggi sono diversissimi tra loro: ci sono dei grandissimi alpinisti, ma ci sono anche degli alpinisti dilettanti. C’è addirittura Alexander Langer, che ho inserito perché rappresentava proprio l’antidoto a questo mal di montagna, che ‘colpisce’ chiunque abbia una passione incondizionata.
Non c’entra che tu sia un grande o un mediocre alpinista. Quello che c’entra è ciò che tu proietti sulla montagna.
Penso che la passione sia una parola a doppio taglio. È qualcosa di cui abbiamo bisogno, almeno io ne ho bisogno. Credo che tutti i ragazzi ne avrebbero bisogno. È difficile diventare uomini e donne senza una passione. Però è anche un’arma letale: la passione è anche quella di Gesù sul Calvario.
Di questa passione non puoi scegliere di prendere solo il lato buono, perché entrambi coesistono, sono indivisibili. E allora bisogna imparare a gestirla questa passione, perché non sia lei a dominare te.
In questo libro racconto storie in alcune delle quali è stata la passione ad averla vinta: ci sono stati dei personaggi che veramente a un certo punto sono stati divorati da questa passione e poi, con il tempo, diventa difficile cambiare, perché arrivati a quel punto pensano “ormai, cerco di fare ancora tutto quello che riesco a fare”. Invece è proprio in quel momento che si dovrebbe scendere con i piedi per terra, che non vuol dire rinunciare alla passione, ma trasformarla in qualche misura.
Questo vale anche per un rapporto d’amore: all’inizio c’è l’innamoramento, ma poi anche quello deve evolvere, altrimenti si brucia.
La passione è interessante se vista da questo punto di vista. Nel libro ne parlo solo attraverso delle storie, però si potrebbe anche approfondire il tema dal punto di vista psicologico. Perché la passione, come ho detto prima, è una cosa meravigliosa, ma è anche un’arma letale.

Aspettiamo il seguito allora. Però torno sul termine ‘malattia’.
Sì, malattia: una bella malattia, però pur sempre una malattia, perché non è così semplice liberarsene, ci sei dentro. Se la passione è vera, reale. Io non conosco tanti che se ne siano liberati facilmente. Quelli che l’hanno fatto ci hanno investito tantissimo. È un problema non facile da risolvere nell’alpinismo.
Io credo che nel grande alpinismo, ma anche in quello della domenica, è pieno di gente malata di montagna. E non è solo negativo: è molto meglio essere malati di montagna che di altro. Però sottolineo che è sempre una malattia, ed è qualcosa che devi gestire, che devi curare in qualche modo.
Anche Hans Kammerlander ha scritto ‘Malato di montagna’ e ha scelto questo termine.
Anche lui è molto sincero, secondo me.
Io sono sicuro che se non avessi vinto, superato questa malattia, se non avessi trasformato questa passione, non sarei diventato uno scrittore, perché tutto quello che avevo e che ho dentro, non sarebbe uscito, ma sarebbe stato compresso dal mio bisogno di scalare.
A volte bisogna un po’ azzerare noi stessi per far nascere qualcosa di nuovo.
Tendiamo a considerare alpinisti più bravi i comunicatori più efficaci. Esistono ancora oggi Casarotto, Cozzolino e altri sconosciuti, grandi alpinisti, ma che non sanno comunicare o non lo vogliono fare?
Sì, credo che esistano, anche se oggi è un po’ cambiata la comunicazione. Oggi avviene prevalentemente via social, quindi è molto rapida e c’è poca elaborazione dell’avventura.
Abbiamo pochi libri, ad esempio, perché un libro richiede tempo: capita di tornare sul pezzo più volte e mettersi a scrivere dopo 6 mesi. Invece il fatto di raccontare subito tutto, in diretta, porta a comunicare in modo superficiale, secondo me.
E si comunica tutti alla stessa maniera: basta avere un canale social e tutti dicono ‘ho fatto questo, ho fatto quello’, ma manca l’elaborazione. Ok, hai fatto, però magari nel mucchio questa cosa potevi anche non raccontarla, perché non è così significativa. Oppure, se è stata così importante per te, dovevi raccontarla da un altro punto di vista, attraverso la tua storia, non come se fosse una grande impresa.
E poi sì, penso ci siano delle persone che non lo dicono proprio quello che fanno. A mio parere meno di una volta, ma ci sono ancora.
Tutta questa comunicazione andrebbe un po’ spolverata, pulita, perché oggi c’è molta confusione.

Possiamo dire che tra gli alpinisti più bravi al mondo ce n’è qualcuno che non conosciamo?
Io credo di sì. Ad esempio certi americani e inglesi, che sono straordinari, ma non lo dicono proprio perché fa parte del loro essere, della loro cultura. L’avventura innanzitutto.
Poi chissà, un Marc-André Leclerc se non gli avessero fatto il film, noi magari non avremmo saputo chi fosse.
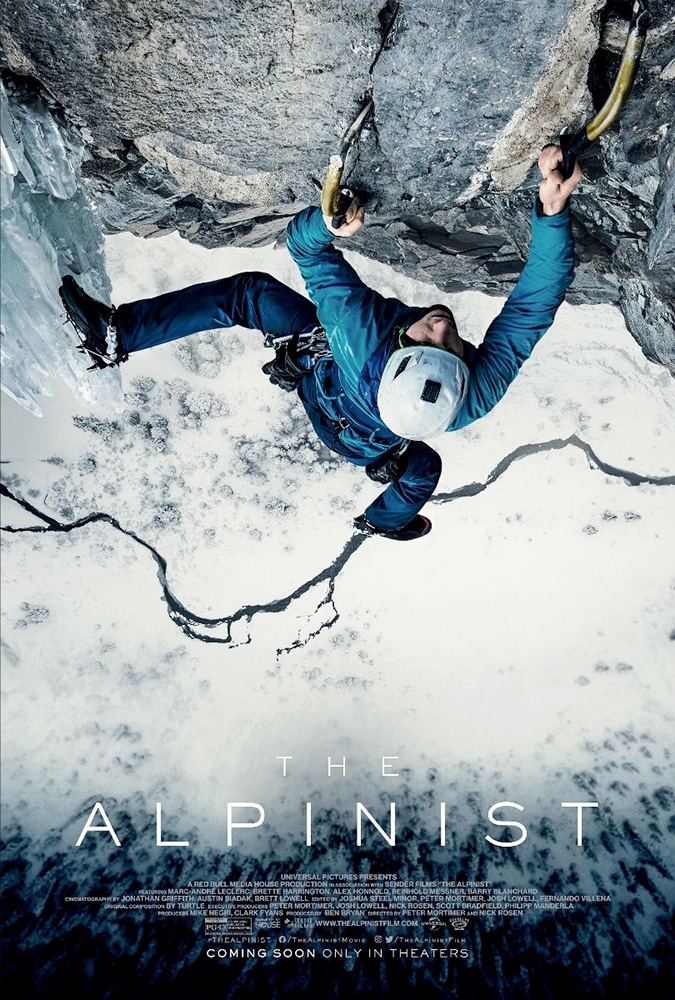
Un alpinista che secondo te è stato il più creativo e lungimirante…
Io credo che un genio dell’alpinismo sia stato Giusto Gervasutti. E lo dico non perché sono torinese, anzi, al contrario, qui a Torino ce l’hanno somministrato fin da piccoli e quindi potremmo anche avere la reazione opposta (ride, ndr).
Ho scritto la sua biografia e mi sono accorto che era veramente un genio della scalata. In certi giorni non aveva nessuna voglia di scalare, per esempio, e passava un sacco di tempo a perdere tempo, non era uno di quelli sempre attivo, sempre al massimo, anzi. Però quando aveva in testa una cosa, la realizzava in un modo straordinario. Era un visionario, apriva delle vie meravigliose, anche dal punto di vista estetico.
Non posso dire che sia il più grande, ma uno dei grandi sicuramente.

Nella tua carriera hai conosciuto moltissimi alpinisti. Chi hai davvero ammirato e perché?
Uno che mi è stato molto caro è Patrick Berhault, perché eravamo coetanei, ci conoscevamo bene, anche se non siamo mai andati a scalare insieme. Ci vedevamo per questioni di lavoro, dato che io facevo il giornalista di montagna e lui l’alpinista.
Patrick era uno che quando andavo a prenderlo con la mia 127, una macchina scassatissima, lui mi ricordava che la mia auto aveva dei problemi nel motore, oppure mi chiedeva di mio figlio: si ricordava tutto di me, e non perché io fossi un giornalista, ma perché era uno così, attento alle persone, a prescindere da quello che loro erano. Questo me l’ha reso sempre molto caro. Quando è morto tentando d’inverno tutti i 4000 delle Alpi, mi sono detto “ma Patrick, potevi smettere un po’…”.
So che è difficile dirlo a un alpinista così formidabile, con un talento e una forza eccezionali, però ha buttato via mezza vita, che avrebbe potuto dedicare ad altro.
Sì, direi Patrick Berhault.

È stato una delle vittime della passione, secondo te?
Direi di sì.
Aveva un’umanità profonda e non era solo: aveva tanti amici, delle figlie… però forse non è riuscito a fare quel passetto indietro. Ma non voglio giudicare.
Certo. Sono comunque scelte meravigliose per chi le fa: dirò una banalità, ma è morto facendo quello che lui voleva, quello che gli piaceva.
Esatto.
Da alpinista, ma soprattutto da giornalista esperto, quali sono stati gli anni più belli dell’alpinismo? Quando questo si faceva nel modo più puro, secondo la tua visione?
Io credo che non ci sia mai stato un momento di purezza. La purezza è retorica.
Gli alpinisti sono sempre stati competitivi, sono anche stati cattivelli a volte, altre buoni, ma non particolarmente migliori degli altri.
È cambiata, secondo me, la retorica: si è passati da quella romantica, l’alpinismo ottocentesco di pochi privilegiati che potevano permettersi di esplorare le Alpi, a un periodo eroico, quello della Grande Guerra e del fascismo, e anche dei primi anni del ’50, in cui la montagna era sacrificio, croci, battaglie, conquiste. Quello secondo me è stato un periodo brutto, dal punto di vista dei significati, però c’erano degli alpinisti magnifici, che se ne fregavano di guerra e politica.
Gervasutti, Cassin, Detassis, Soldà o altri, di cui più di uno era stato fascista, ma non nell’anima, in montagna andavano perché gli piaceva, la vivevano con gli amici. Non tutti, ma l’amicizia era importante già allora.
Quegli alpinisti non erano come li dipingeva il regime.
Io qualcuno l’ho conosciuto, qualcuno no perché erano molto più anziani, però sono sicuro che in quel periodo fossero veramente appassionati. Era spesso la politica a costruirgli addosso un abito di forza.
Poi è venuto il periodo del Nuovo Mattino, che è stato un po’ il superamento di questo alpinismo eroico, che a noi dava tanto fastidio. Il Nuovo Mattino è stato un periodo magnifico, durato pochissimo. Io sono arrivato alla fine, non l’ho vissuto appieno, ma so che anche lì c’erano dei limiti: ad esempio le ragazze non c’erano in quel periodo, la maggioranza assoluta erano maschi, era ancora un alpinismo ‘maschilista’.
Ci sono sempre limiti, pregi e difetti, non è che ci sia mai stato un periodo d’oro.
Con gli anni siamo poi arrivati allo sport, che ha aspetti bellissimi: a me piace vedere tanti ragazzi appassionati, sereni, e di solito sono molto più simpatici di quanto fossimo noi allora. Ma lo sport è anche limitante, perché se tu vedi solo il grado, la prestazione, ti mancano un sacco di altri elementi. Io credo che in tutte le epoche ci siano i pro e i contro. Non vedo un’epoca d’oro dell’alpinismo.
Poi come sempre, quando si invecchia, è sempre più bello quando eri giovane, no? (Ride, ndr)
È riduttivo dire che l’arrampicata sportiva è figlia dell’alpinismo?
Secondo me l’arrampicata sportiva è figlia di un ragionamento abbastanza raffinato che hanno fatto in particolare due persone, Cassarà, che era un giornalista, e Mellano, che era un alpinista. Hanno detto “gli alpinisti sono sempre stati competitivi, solo che non hanno il coraggio di ammetterlo. Allora noi facciamo le gare di arrampicata, li mettiamo a confronto (che è stato uno scandalo, perché c’è chi ha gridato al sacrilegio) e vediamo cosa capita”.
È stata una grande festa, un bellissimo momento, avevano ragione loro.
Io ero tra quelli invece che avevano dei dubbi, anche se poi ho seguito da giornalista l’avvenimento. Quando ho visto che lo sport era sport, ho capito che le due strade si sarebbero separate. Quindi l’arrampicata è stata un po’ figlia di questa intuizione, del provare a isolare l’alpinismo da tutto il suo contesto, come rischio e ambiente.
È capitato quello che è capitato, e siamo arrivati anche alle Olimpiadi.
Io non giudico, però affermo che alpinismo e arrampicata sportiva sono due cose completamente diverse, perché se all’alpinismo togli il rischio, non è più alpinismo. E se all’arrampicata sportiva aggiungi il rischio, non è più arrampicata sportiva.
È stato un bene che sia nata l’arrampicata sportiva, secondo te, o semplicemente è stata una naturale evoluzione e così doveva essere?
Secondo me è stato un bene, perché si è fatta un po’ di chiarezza. E poi devo dire che gli alpinisti non dovrebbero lamentarsi dell’arrampicata sportiva, perché tutti la pratichiamo, tutti ci divertiamo e un pochino serve a chiunque, non trovi? Avere delle palestre dove andare anche in inverno a divertirsi non è male!
E poi se io voglio cercarmi delle grane in montagna, lo posso fare quando voglio, e lo stesso per la palestra: ognuno è libero di fare quello che gli pare.
Quindi sì, alla fine secondo me è stato un bene.
Andrea Giorda mi ha raccontato di quella volta che è stata inaugurata una palestra e Motti ha deciso di non andare. Tu c’eri?
La palestra dedicata a Guido Rossa al PalaVela di Torino. No, non c’ero.
Io parlavo tanto con Gian Piero, quindi so benissimo come la pensava. A lui non piaceva questa cosa. Per lui l’alpinismo aveva una dimensione romantica, di avventura: era il più antieroico che esistesse sulla terra, però era molto romantico e lo sono anch’io. Lui era più grande di me, era più intransigente di me, per lui il passare da una attività libera all’aria aperta, un po’ misteriosa, a un’attività al chiuso, con i giudici, con le prese artificiali, era un sacrilegio.
Però Motti è morto nell’’83, quindi bisognerebbe vedere adesso come la penserebbe, perché le persone possono cambiare.
Sai, io adoro Motti attraverso i suoi scritti, ma mi sembra strano che una mente come quella di Gian Piero Motti, così illuminata, con potenzialità eccezionali nello scrivere quello che ha scritto, libera e aperta, sia stata un po’ ‘chiusa’ da questo punto di vista… Non sembra strano anche a te?
Sì, lo è, però tutti siamo pieni di contraddizioni. E lo era pure lui. Gian Piero è una delle menti più brillanti che ho conosciuto, ma anche le menti più brillanti possono sbagliare, possono prendere delle derive. Altrimenti non sarebbe un uomo, ma una macchina.
E poi c’è da dire che in quegli anni, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, quando è partita l’arrampicata sportiva, è stato un momentaccio, secondo me.
Da un lato si sono liberati gli orizzonti con i vari Manolo, Berhault, che hanno fatto cose meravigliose e sono caduti i tabù. Loro sicuramente si sono divertiti, ma erano persone della mia età, gente che aveva già vissuto anche il periodo precedente. Invece i giovanissimi, quelli che allora avevano dai 15 ai 20 anni, sembravano delle scimmie, tutti vestiti uguali. Dopo le rivoluzioni arriva sempre un conformismo che fa paura.
Gian Piero non tollerava questo. Anche a me dava fastidio i primi tempi. Poi però tutto si ridimensiona, si riequilibra, e oggi non c’è assolutamente più quell’atteggiamento.
Ma tu immaginati un mondo un po’ elitario, come quello di Motti, accessibile a chi aveva non tanto mezzi economici, ma soprattutto culturali, un mondo che tutto ad un tratto diventa una palestra a cielo aperto: forse è stato un po’ scioccante il passaggio e lui non ha visto il seguito, purtroppo.

Da Preuss a Honnold, cosa ne pensi del free solo? Pochi giorni fa ho intervistato Dell’Agnola e mi ha detto che per lui il free solo è l’espressione pura dell’arrampicata. Tu cosa ne pensi?
Penso che abbia ragione lui. E che abbia ragione anche Manolo, quando dice che se tu fai un metro e mezzo di scalata in solitaria e non sei sicuro, torni indietro. Quindi che Honnold porti i ragazzi a morire, come dice qualcuno, secondo me non è proprio vero, perché io ho fatto qualche solitaria facile e appena ti stacchi da terra posso assicurarti che ti accorgi che la vita è nelle tue dita: è tutta una questione di testa e se tu in quel momento non sei tranquillo, devi scendere.
Io non credo più di tanto ai ‘cattivi maestri’, perché alla fine ci si ridimensiona.
Certo che gente come Honnold ha una soglia della paura altissima: lui prima di avere paura deve arrivare al limite, e questo gli consente di essere assolutamente tranquillo dove qualunque persona normale tremerebbe. Dunque è anche abbastanza soggettivo, probabilmente.
Io lo ammiro, però spero che non diventi una pratica comune. Ma non credo.
Honnold è un ragazzo dolcissimo, corretto e non ha niente di eroico, quindi dovremmo anche smettere con gli stereotipi, secondo me. Non esistono modelli, questo è il bello.
Qual è la forma più pura dell’arrampicata allora, secondo te?
Preferisco utilizzare ‘forma migliore’ e secondo me è quella dove tu sei in pace con te stesso, dove esprimi al meglio le sensazioni che hai dentro. Quindi esistono tante forme, ma è anche chiaro che se tu vai a riempire di tasselli una parete oppure a scavare gli appigli e altre stupidaggini così, vuol dire che non sei in pace con te stesso.
Senti Enrico, in alpinismo conta l’onestà, perché sei solo e non sempre il tuo compagno di cordata riesce a vederti, quindi è necessario essere sinceri. Quanto sono onesti gli alpinisti, secondo te?
Secondo me sono onesti fino a un certo punto, ma questo mi piace, non lo demonizzo. C’è un margine di, non dico falsità, ma di ambiguità nei racconti degli alpinisti, perché l’alpinismo è in sé un mistero, è un’attività che fai da solo.
Certo che poi se tu racconti balle per tutta la vita, non va bene, ma quel margine di ambiguità secondo me ci sta, si può tollerare, perché se togliamo anche quello, allora diventa una cosa troppo banale.
Lasciamo che l’alpinismo sia un po’ leggendario, misterioso, così mi sta bene.
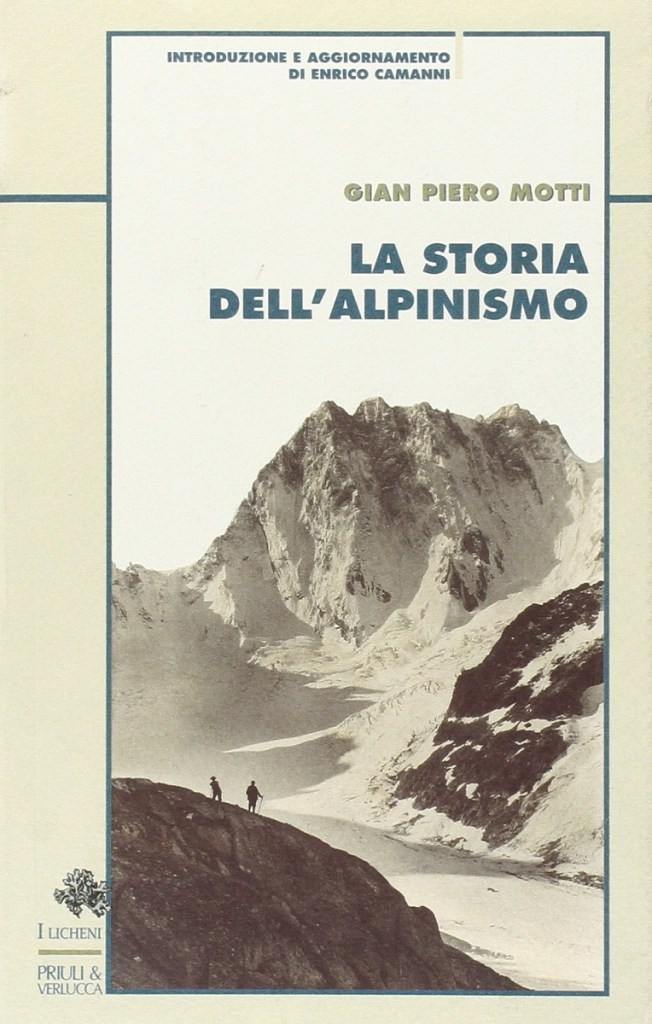
Qui però stai parlando più da scrittore che da giornalista, no?
Sì, infatti quando ho aggiornato la Storia dell’alpinismo di Motti, mi arrabbiavo quando non era chiaro un concetto: “ma ora cosa scrivo io? C’è uno che dice una cosa, l’altro che dice il contrario…”. Se uno fa lo storico, deve avere degli elementi su cui basarsi. Certo, scrittore e giornalista sono due mestieri diversi.
Dev’essere difficile fare lo storico dell’alpinismo: non sai mai se un’informazione è davvero reale!
Molto difficile. Infatti la cosa bella di Gian Piero è che lui entrava nell’anima degli alpinisti, più che nella loro prestazione pura. E allora tu dai un contenuto alle imprese a prescindere dal grado: così diventa interessante.
Se uno dovesse basarsi solo sul grado, sui tempi, c’è poco da raccontare.
Adesso la comunicazione tende più a spostarsi, soprattutto tra i giovani, verso il grado.
Questa è la deformazione dello sport.
Però chiediamoci allora che cosa ci dicono certe prestazioni sportive: campioni dello sport fanno delle cose eccezionali, ma non sono interessanti, perché sono talmente eccezionali che ormai sono quasi sdoganate. Se dietro non c’è una storia, non ci dicono niente. E questo vale per tutti gli sport.
Se dietro non c’è una ‘persona’, a mio parere lo sport perde significato, interesse, e quindi anche l’arrampicata deve stare attenta, perché se diventa solo numeri, non interessa più a nessuno, tranne a quei quattro gatti che fanno a gara per salire una via.
Apro un’altra parentesi su Motti: qual è stato l’insegnamento più utile che ti ha dato quando hai lavorato con lui in redazione?
Mi ha dato ottimi consigli soprattutto come storico, proprio perché lui aveva una conoscenza della storia dell’alpinismo completa e, come dicevo prima, lui sapeva entrare nel cuore delle persone, a volte anche facendo delle interpretazioni un po’ ardite. Ricordo che a volte scriveva anche delle vicende che non erano avvenute proprio così, ma entrava nelle esperienze. E poi lui conosceva bene le montagne, gli itinerari, gli alpinisti, i periodi storici: così puoi essere un buon storico.
Gian Piero mi ha aiutato a inquadrare i fenomeni nella loro complessità.
Quando siamo andati a intervistare Renato Casarotto, a Vicenza la prima volta dopo il Huascaran, è stato un viaggio epico sulla mia 127: c’erano Motti e Giorgio Daidola, il direttore della Rivista della montagna. Renato era timidissimo e Goretta parlava solo vicentino stretto, così lui traduceva in italiano e ricordo che gli abbiamo detto “Renato, guarda che capiamo!” e lui voleva comunque farlo.
Gian Piero aveva già tutta la sua interpretazione in testa di questo ambiente, molto provinciale, e riusciva sempre così a costruire una storia più ampia della semplice scalata, che di per sé non dice molto, pur essendo stata eccezionale per l’epoca.
Però, correggimi se sbaglio, Motti non è mai stato in Yosemite, ma è riuscito comunque a portarlo in Italia. Dal tuo punto di vista è possibile comprendere e raccontare anche senza aver vissuto? Tu prima mi hai detto che lui conosceva bene anche gli itinerari e grazie a questo riusciva a raccontare al meglio le vicende.
Infatti l’articolo sull’alpinismo californiano è un po’ azzardato, perché lui non era mai stato in Yosemite. Aveva parlato con Patrick Cordier, che aveva fatto la solitaria del Nose nel ’72.
Devo dire che oggi sono ancora stupito da quanti pochi errori facesse lui, pure azzardando. Era talmente bravo a leggere le riviste straniere, ad ascoltare, a farsi un’idea, che raramente faceva lo scivolone. Oggi però forse gli direi “facciamoci un giro prima di raccontare queste cose”.
Era comunque un azzardo molto calcolato: lui sapeva che aveva dei buoni margini.
Tu hai continuato il lavoro di Gian Piero Motti, la Storia dell’alpinismo: com’è stato proseguire il suo lavoro?
È stato difficile, innanzitutto per quello che mi legava a lui: non volevo provare a scrivere come lui, sarebbe stato assurdo. Ed erano tempi che lui probabilmente avrebbe in qualche misura detestato: arrampicata sportiva, grandi concatenamenti, velocità…
Mi ricordo che la prima volta, prima di cominciare l’aggiornamento del libro, sono andato in Val Grande di Lanzo, la sua valle, da solo in un giorno di inverno (o primavera, non ricordo bene) a farmi un giro, per respirare un po’ la sua aria, per ricordarmi un po’ chi era lui. In quel posto c’era casa sua. L’ho fatto per entrare un po’ nel mood, ma a un certo punto mi sono detto “io faccio questo di mestiere, devo fare il mio lavoro” e quindi mi sono letto tutto quello che potevo leggermi.
Oggi non sarei più in grado di farlo, perché l’informazione alpinistica è talmente sfaccettata, complessa, che non sai più da che parte attaccarti.
Quel momento, secondo me, erano gli ultimi anni in cui ancora si poteva scrivere una buona storia dell’alpinismo. Oggi sarebbe veramente difficile.
Facciamo un salto nel tempo e cambiamo argomento: parliamo di limite, ma questa volta a livello ambientale: lo stiamo forse oltrepassando, secondo te?
Sì.
Ti chiedo se un giorno secondo te le montagne si ribelleranno all’uomo. Ti chiedo anche se sono termini corretti quelli che ho utilizzato, oppure addirittura se questo sta già accadendo.
Secondo me sta già accadendo.
Noi ci preoccupiamo tanto del pianeta, ma quelli di cui dovremmo preoccuparci siamo noi, perché il pianeta si salva benissimo da solo, può durare altri milioni di anni, non ha bisogno di una certa temperatura, non ha bisogno del ghiaccio. Noi in teoria eravamo una specie adattabile e oggi siamo una specie statica, perché il nostro sistema di sviluppo è statico. Lo hanno dimostrato i vari accordi di Parigi, che poi non hanno portato a nulla.
Quindi la montagna ci sta dando tutti i segnali che ci servirebbero. Il fatto che i ghiacciai si ritirano quasi a vista d’occhio, che quando arriva l’alluvione è più di rompente di una volta, che quando c’è la siccità ci sono ambienti senza acqua anche a 2000 metri… Sono tutti segnali di un mondo che abbiamo alterato oltre misura.
Abbiamo il vantaggio che la montagna queste cose ce le dice un po’ prima della pianura. Il primo segnale viene dalla montagna e noi dovremmo leggere questi segnali. Poi, una volta letti, mi chiedo cosa possiamo fare, perché fino a ora non siamo stati capaci di fare niente.
Dubito che nei prossimi 20 anni riusciremo a ridurre veramente le emissioni di CO2, come è stato chiesto dalla scienza, però almeno dovremmo renderci conto di quello che stiamo combinando e non far finta di niente.
Mi dà abbastanza fastidio il negazionismo, che è ridicolo, ma anche il fatto di continuare a ballare sul Titanic mentre va giù.
Ci sono tantissimi giovani che vogliono fare le guide alpine. A me vengono in mente le famose file sulle montagne Himalayane, le corde fisse… Secondo te saranno anche le guide alpine, e le altre figure professionali e non, responsabili dello sfruttamento della montagna, portando la massa in quota? Oppure possono fare qualcosa per tornare alla normalità, se così si può dire?
Io ogni anno faccio il corso di storia dell’alpinismo ai corsi guida, conosco tutti gli aspiranti, giovani e non, molto preparati, più di una volta, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello culturale. Penso che possono fare molto, e credo lo faranno, per tutelare la montagna. Il fatto che uno sia un buon professionista, lo porta a fare delle scelte corrette, oneste.
Certo, tu mi dirai ‘allora chi porta tutta quella gente in coda sull’Everest?’. Sono guide anche quelle, effettivamente. Però io credo che un miglioramento della professionalità non possa che portare a benefici. Invece quando si scivola nel populismo, tutti vanno, tutti fanno, tutti dicono: è un disastro.
Io vorrei chiedere alle guide che hanno salito l’Everest con i clienti in queste condizioni che cosa ne pensano. Non sono scelte molto educative, secondo me, rispetto all’alpinismo.
Anche sul Cervino accade questo, il sovraffollamento e le corde fisse: quindi non è poi molto diverso quello che facciamo sulle Alpi da 100 anni.
È un problema complicato, però credo che le guide del domani dovrebbero portare le persone a cercare delle altre strade, meno conosciute e più tranquille, naturali, semplici. Se riuscissero, sarebbe un grande passo avanti. E non solo le guide.
Quindi togliere le corde fisse?
No, però magari dire al cliente “invece di andare lì dove facciamo la coda, andiamo in un altro posto, su un’altra montagna”, per esempio. Ormai le corde fisse restano. È difficile tornare indietro.
Però invece di salire il Cervino con le corde fisse, possiamo salire montagne lì vicino, dove avremmo un altro tipo di esperienza. Se il cliente comprendesse questo, secondo me sarebbe un piccolo passo avanti per tutti.
È anche colpa di questa nuova comunicazione più social?
Probabilmente sì.
Oggi si dovrebbero porre dei limiti etici per salvaguardare la montagna. Qual è il limite nel mettere dei limiti, per non intaccare quella libertà che è caratteristica dell’alpinismo e del vivere la montagna?
Io credo che il limite imposto non serva a niente. Il limite devi comprenderlo, altrimenti lo vivi come una coercizione e non aspetti altro che trasgredirlo.
Il limite deve essere una questione culturale. Ti faccio un esempio: quando Petrini e i suoi hanno cominciato Slow food, a dire che bisognava mangiare in un certo modo, perché il cibo da supermercato faceva schifo, sia a livello sociale sia alimentare, appariva come un limite. Lui voleva dire che dobbiamo mangiare bene, magari spendere un po’ di più, produrre meglio e dare più lavoro a quelli che producono biologico. Quello è un limite, evidentemente. Adesso però questo limite è diventato un’acquisizione culturale: molti capiscono che vale la pena spendere un po’ di più, se posso permettermelo, per mangiare meglio e per dare lavoro a persone che producono meglio.
Ecco, questi sono i limiti che hanno un senso, quando diventano acquisizioni culturali.
Nel nostro ambito, sarebbe necessario lavorare molto con il CAI e con tutti quelli che hanno voce in capitolo per dire che questo limite, tutelare la montagna e l’ambiente, è un progresso, un’evoluzione. Però è importante che ognuno di noi lo capisca, che ci arrivi da sé, perché se è un’imposizione non funziona. In pista metto il casco non perché qualcuno mi dice che devo farlo, ma perché non mi rompo la testa. Obbedire solo agli ordini senza capire il problema, non serve.
Altrimenti prevale l’illusione della sicurezza, che oggi è diventata anche una persecuzione.
Falesie sicure certificate, cosa ne pensi?
Meglio non parlare di questo, altrimenti dovremmo aprire un altro capitolo molto lungo (ride, ndr).
Ti chiedo di raccontarmi una tua scalata, di cui varrebbe la pena scrivere un libro, e con chi l’hai fatta.
Mi vergognerei a scrivere un libro su una mia scalata.
Ricordo la gita che ho fatto quando avevo 7 anni al Breithorn, il mio primo 4000, il mio mito… Io già a 7 anni avevo questo pallino e sono andato con mio papà e alcuni amici. C’è una foto che sembro un pupazzetto in cima a questa montagna. Mi piacerebbe raccontare lo stato d’animo che avevo quel giorno, la passione di un bambino per una cosa assurda, come salire una montagna. E che di notte ho sentito suonare tutte le ore dell’orologio a cucù che avevamo in casa. Praticamente non ho dormito. Narrare quella visione, di un bambino, mi piacerebbe ma non sono capace. È troppo difficile.
Che futuro avrà l’alpinismo nei prossimi anni, secondo te?
Mah, è ormai tanto tempo che l’alpinismo secondo me si evolve poco: le prestazioni salgono sempre più di livello, però più o meno i filoni sono quelli. Faccio un po’ fatica a dire se cambierà.
Mi sembra un po’ incagliato in uno stato che non è né buono, né cattivo: si fanno belle avventure, grandi prestazioni, ci sono tanti alpinisti che esplorano, c’è gente bravissima, però la novità non la vedo, e non so se sia facile trovarla a questo punto.
Ma questo succede anche nella musica, in tante altre attività, non solo nell’alpinismo, che è un mondo comunque poco propositivo, dove tutti ripetono quello che fanno gli altri. È difficile trovare una propria strada in questo momento, quindi non ho la risposta. E mi spiace, perché mi piacerebbe averla.
Forse quella del free solo potrebbe essere una strada.
È una delle strade in cui sicuramente si sta procedendo, ma anche nel ghiaccio, nel dry tooling, fanno cose pazzesche, però non so se culturalmente queste attività siano figlie di un altro pensiero. Forse no. Chissà se ci sarà un’altra storia dell’alpinismo…
Abbiamo esplorato il mondo, le montagne, e forse l’esplorazione dovrebbe diventare più interiore che che fisica. Vedremo.
Gli ideali dei giovani sono spesso considerati utopie e le ribellioni dei semplici sfoghi da ragazzini che non sanno come va il mondo. Ma senza questi ideali e queste ribellioni ci sarebbe ben poco oggi. Ci saranno ancora Nuovi Mattini?
Io sono sicuro di sì, altrimenti il mondo finirebbe domani. Il Nuovo Mattino è inteso come ribellione, appunto, come un nuovo modo di vedere. È l’unica cosa che ti fa cambiare, l’unica cosa che ti fa andare avanti in tutti i campi. È sempre stato così e sempre sarà così.
Però i Nuovi Mattini li possono generare solo i giovani, non i vecchi, perché sarebbe contro natura.
Io penso di essere in grado di capirli perfettamente, penso di poterli appoggiare, ma la scintilla deve scaturire da qualche ragazzo, e di questo sono assolutamente sicuro. La casistica ci dice che l’ultima generazione è sempre stata quella che ha cambiato le cose e credo che succederà ancora.
Io litigavo con mio papà, che era riformista a oltranza, e io ero un rivoluzionario. O forse no, ma credo che il cambiamento avvenga se c’è una frattura, una crisi, uno strappo.
È importante cercare il dialogo, la dialettica, opporre al bianco un altro colore, altrimenti rimarremmo in questo limbo dorato, dove in fondo stiamo bene.
Il Nuovo Mattino è stato uno strappo con il passato eroico, uno strappo culturale: solo così, secondo me, nasce un nuovo modo di vedere le cose.


Di’ la tua!